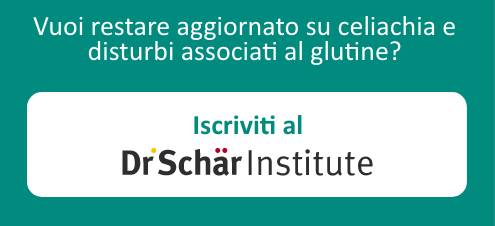Disturbi cutanei nella celiachia: una guida per i pazienti
Settembre 4, 2025
La celiachia è una malattia autoimmune che, oltre a colpire l’intestino, può manifestarsi anche a livello cutaneo. La dermatite erpetiforme (DE) rappresenta la manifestazione dermatologica più tipica e ben documentata, tanto da essere considerata la “forma cutanea” della celiachia. Tuttavia, negli ultimi anni è emerso un possibile legame anche con altre condizioni della pelle, come psoriasi, dermatite atopica e orticaria cronica. Studiare e comprendere queste associazioni è importante non solo per una gestione terapeutica mirata, che ruota attorno al principio cardine della dieta priva di glutine, ma anche perché può offrire nuove chiavi di lettura per approfondire i meccanismi stessi della celiachia.
Dermatite erpetiforme: dalla diagnosi al trattamento
La dermatite erpetiforme (DE), o malattia di Duhring, è la più comune manifestazione cutanea della celiachia. Si presenta con papule e piccole vescicole molto pruriginose, disposte “a grappolo” (pattern erpetiforme: l’aspetto ricorda quello dell’herpes, ma non è un’infezione da herpes virus). Le sedi tipiche sono: gomiti, ginocchia, glutei e schiena.
Perché è legata alla celiachia? Nella celiachia il sistema immunitario produce anticorpi IgA contro la transglutaminasi tissutale (TG2). Nella dermatite erpetiforme (DE), invece, il bersaglio principale è la transglutaminasi 3 (TG3), un enzima “parente stretto” della TG2 ma localizzato nella pelle. Non è ancora del tutto chiaro perché si formino questi autoanticorpi; l’ipotesi più accreditata è che, per somiglianza strutturale e per un meccanismo chiamato epitope spreading (allargamento dei bersagli immunitari), in alcune persone celiache compaiano anche anticorpi anti-TG3 (1). Le IgA così prodotte si depositano in modo granulare nelle papille dermiche, innescando l’infiammazione cutanea tipica della DE.
La diagnosi di DE si basa su tre criteri diagnostici principali (1):
- Diagnosi accertata di celiachia.
- Presenza dei segni caratteristici della DE a livello cutaneo.
- Biopsia cutanea con immunofluorescenza diretta: rilevazione di IgA a pattern granulare nella parte superiore delle papille dermiche.
Come si tratta? Il cardine della terapia della DE è la dieta priva di glutine (2). Un’aderenza rigorosa e continuativa porta a un netto miglioramento clinico: i primi benefici compaiono in poche settimane o mesi, mentre la remissione completa dei sintomi può richiedere fino a circa 2 anni (1).
Nei casi più severi, nell’attesa che la dieta faccia effetto, può essere indicata una terapia farmacologica: il dapsone è il farmaco di prima linea e consente un rapido controllo di prurito e lesioni. Va però considerato come supporto e non sostituisce la dieta senza glutine (2).
Altre manifestazioni cutanee associate alla celiachia
Il legame tra dermatite erpetiforme (DE) e celiachia è ben documentato. Esistono però altri disturbi cutanei osservati più spesso nelle persone celiache, pur senza un collegamento causale dimostrato né un meccanismo patogenetico definito (1):
- Psoriasi: alcuni studi riportano una prevalenza maggiore nei pazienti celiaci e livelli aumentati di IgA anti-gliadina; in questa sottopopolazione l’adozione di una dieta priva di glutine può associarsi a un miglioramento dei sintomi (1).
- Dermatite atopica: è stata riscontrata una prevalenza maggiore sia negli adulti sia nei bambini con celiachia rispetto alla popolazione generale (1).
- Orticaria cronica (OC): diversi studi hanno analizzato il legame tra OC e celiachia. In un ampio studio di coorte è stato evidenziato un rischio aumentato di circa 1,9 volte per lo sviluppo di OC nei pazienti celiaci (3). Inoltre, in alcuni bambini con OC e diagnosi di celiachia, l’adozione di una dieta priva di glutine ha portato alla remissione completa dei sintomi cutanei, anche se il numero di casi riportati è ridotto e sono necessari ulteriori studi per confermare l’associazione (4).
- Didona, D., Maglie, R., & Solimani, F. (2025). Gluten-related skin disorders: clinical presentation, diagnostic and treatments. Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft = Journal of the German Society of Dermatology : JDDG, 23(7), 857–867. https://doi.org/10.1111/ddg.15704
- Görög, A., Antiga, E., Caproni, M., Cianchini, G., De, D., Dmochowski, M., Dolinsek, J., Drenovska, K., Feliciani, C., Hervonen, K., Lakos Jukic, I., Kinyó, Á., Koltai, T., Korponay-Szabó, I., Marzano, A. V., Patsatsi, A., Rose, C., Salmi, T., Schmidt, E., Setterfield, J., … Sárdy, M. (2021). S2k guidelines (consensus statement) for diagnosis and therapy of dermatitis herpetiformis initiated by the European Academy of Dermatology and Venereology (EADV). Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 35(6), 1251–1277. https://doi.org/10.1111/jdv.17183
- Ludvigsson, J. F., Lindelöf, B., Rashtak, S., Rubio-Tapia, A., & Murray, J. A. (2013). Does urticaria risk increase in patients with celiac disease? A large population-based cohort study. European journal of dermatology : EJD, 23(5), 681–687. https://doi.org/10.1684/ejd.2013.2158
- Caminiti L, Passalacqua G, Magazzù G, et al. Chronic urticaria andassociated coeliac disease in children: a case-control study. PediatrAllergy Immunol. 2005;16:428-432